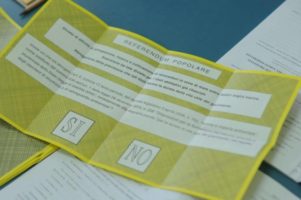Donne e impresa teatrale – Intervista a Stefania Bruno

Si è tenuto lo scorso 10 e 11 giugno Donne e impresa teatrale, un convegno dedicato a La nascita delle cooperative teatrali dagli anni ’70 a oggi. Ridefinizione dei ruoli femminili all’interno dei nuovi scenari organizzativi, produttivi e artistici.
La Cooperativa En Kai Pan, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, ha organizzato tale iniziativa, coinvolgendo le professioniste del settore, per rinarrare il ruolo delle donne all’interno della cooperazione teatrale in Italia dagli anni Settanta del Novecento a oggi, a stimolare il dialogo tra la comunità accademica, il mondo delle imprese culturali e quello del lavoro e a contribuire alla costruzione di una cultura femminile del lavoro.
Il Mezzogiorno ha intervistato Stefania Bruno, socia della Coop. En Kai Pan e organizzatrice del convegno insieme a Tiziana Sellato e Loredana Stendardo.
Com’è nata l’idea del convegno?
Il primo nucleo del progetto Talking about a revolution – La donna nella cooperazione è nato nel 2017. All’interno del nostro festival I viaggi di Capitan Matamoros ospitammo Claudia Contin Arlecchino con lo spettacolo Né serva né padrona, sulle donne della Commedia dell’Arte. Approfittammo dell’occasione per invitare Dora Iacobelli, di CoopFond, e Roberto Calari, che in quel momento era il presidente di CulTurMedia, a un seminario in cui presentammo la fraternal compagnia di Commedia dell’Arte come un primo esempio di struttura teatrale professionistica basata sul mutualismo. Il seminario piacque molto e ci invitarono a ripeterlo al Salone del libro di Torino del 2018. Da lì ci hanno invitate a pensare un progetto più esteso sul tema della cooperazione teatrale e sul ruolo delle donne al suo interno. Ci siamo immediatamente rese conto che il tema non poteva essere trattato da un solo punto di vista, occorreva costruire un terreno di scambio abbastanza vasto. Così abbiamo progettato un convegno in cui ci fossero un tavolo politico, uno storico, uno dedicato al dialogo tra le protagoniste, un laboratorio multimediale sui documenti e una sessione di progettazione. Abbiamo trovato in Paolo Sommaiolo, docente di Storia del Teatro Moderno e Contemporaneo de “L’Orientale”, un partner attento, che ci ha aiutate ad accreditare il convegno e ci ha accompagnate nell’organizzazione. Volevamo, infatti, che temi così importanti come il rapporto tra le donne, il teatro, il lavoro e l’impresa fossero discussi all’interno dell’università e raggiungessero anche un pubblico di studenti. La pandemia, che è iniziata proprio mentre noi stavamo completando il panel del convegno, ha stravolto tutto ma ha anche fatto emergere una nuova necessità rispetto ai temi che avevamo deciso di trattare.
Quale il ruolo della donna oggi all’interno dell’impresa teatrale?
Il ruolo della donna nell’impresa teatrale purtroppo non è ancora emerso del tutto. Nell’ultimo anno abbiamo condotto una ricerca regionale, una specie di spin off del progetto principale, chiamata Donne e impresa teatrale in Campania. Avevamo bisogno di raccogliere dati ma soprattutto testimonianze sul lavoro delle donne in teatro. Abbiamo scoperto che le donne sono presenti a qualsiasi livello, dall’organizzazione, produzione, amministrazione e progettazione (qui per esigenze di sintesi unisco queste funzioni, che sono però molto diverse e a cui corrispondono percorsi di carriera diversi), alla formazione e alla comunicazione. Sono tante le artiste (attrici, registe, drammaturghe) ma anche le tecniche (scenografe, costumiste, macchiniste). Troviamo pochissime donne nei ruoli apicali e questo è un problema, non solo di pari opportunità, ma anche di rappresentanza e conseguente percezione del lavoro delle donne in teatro. Sentiamo troppo spesso dire, ed è successo anche durante il convegno, che non esiste una drammaturgia femminile di rilievo o che sono poche le registe teatrali, ma queste sono affermazioni falsate dal fatto che il lavoro femminile non è abbastanza raccontato e rappresentato. Noi abbiamo ospitato, per esempio e per restare in Campania, Alina Narciso, che ha ideato e organizza da vent’anni la biennale di drammaturgia femminile La Escritura de la/s Diferencia/s, un festival che oggi si svolge tra l’Italia e Cuba e conta una rete di 15 paesi dall’America Latina all’Europa. Se ci spostiamo, poi, sul terreno del lavoro autonomo, sia esso condotto come libere professioniste o come membre di una organizzazione, vediamo che le cose si complicano: le artiste svolgono anche mansioni di organizzazione e di formazione, alternano le produzioni a progetti sociali, sono, in breve, delle operatrici teatrali. Il ruolo dell’operatore teatrale, che è nato proprio in seno al movimento cooperativistico dagli anni Settanta del secolo scorso in poi, oggi è tanto diffuso quanto poco rappresentato, si tende a immaginarlo come una diminutio dei ruoli artistici e organizzativi espressi all’interno del sistema teatrale così come è stato ridisegnato dalla riforma del FUS del 2014, e le piccole imprese teatrali sono troppo spesso assimilate al circuito amatoriale, laddove, invece, sono parte fondamentale di un vero e proprio ecosistema culturale, a iniziativa privata, che sostiene e alimenta anche il sistema statale in molti modi, formando sia le professionalità che poi accedono all’impresa di Stato che il pubblico.
Il suo punto di vista è modificato in seguito al convegno del 10-11 giugno o ha confermato
Obiettivo del convegno non era risolvere dei problemi, ma costruire un territorio in cui si potessero discutere delle questioni e scambiarsi esperienze e considerazioni. Volevamo che le rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati si sedessero ‘virtualmente’ allo stesso tavolo con le storiche e le studiose, le artiste, le organizzatrici e le attiviste, perché troppo spesso tendiamo a raccontarci le cose fra di noi, finendo col chiuderci in una prospettiva limitata e anche paranoica sui problemi. Il taglio del convegno è stato fin dall’inizio multidisciplinare e finalizzato al dialogo. Il risultato più importante è che questo dialogo ci sia stato.
Le sue idee di partenze?
L’idea che abbiamo coltivato fin dall’inizio è stata quella di raccontare il lavoro in teatro dal punto di vista delle donne, non perché sia migliore (spesso quando intraprendi azioni di questo genere, ti senti rispondere “voi volete dire che le donne sono migliori degli uomini”) o semplicemente diverso, ma perché non viene fatto. Basta sfogliare un manuale di Storia del Teatro per rendersi conto che quasi sempre contiene le storie di uomini raccontate dagli uomini. Il femminile è presente come tema, su cui, nemmeno a dirlo, si sono esercitati soprattutto gli uomini. Questa è la percezione che si ha studiando i testi. Il punto di vista è una delle funzioni più importanti di qualsiasi forma di narrazione e oggi gli storici nella ricostruzione di un evento non possono ignorare la soggettività. Il racconto è un terreno su cui si incontrano la soggettività espressa dai personaggi e quella di chi racconta. Se sentiamo una storia raccontata sempre allo stesso modo, non vuol dire che quello sia l’unico modo possibile, ma solo che un punto di vista specifico ha soverchiato tutti gli altri ed è importante essere consapevoli che questo è un gesto politico.
Da quello che è emerso dal convegno, le donne che lavorano nel mondo del teatro che difficoltà incontrano? Hanno problemi a rapportarsi ai colleghi maschi?
I problemi che affrontano le donne nel mondo del teatro sono simili a quelli che affrontano in altri ambiti lavorativi e vanno dalle pari opportunità, al gender paygap e alla cosiddetta conciliazione. Alcuni problemi sono condivisi con gli uomini e lo abbiamo visto drammaticamente in questo anno e mezzo di pandemia: parliamo di contratti, tutele e riconoscimento del lavoro artistico e culturale al di fuori della sfera dell’intrattenimento, o, peggio, del divertimento, che è come dire che chi fa divertire gli altri (qualsiasi cosa significhi) lo fa perché si diverte a farlo e non perché è il suo lavoro. La parità è un concetto molto diverso dall’uguaglianza, deve poter essere declinato in tutti gli ambiti della vita e il lavoro è un ambito fondamentale. È come se ci muovessimo sempre in uno schema sintattico sbagliato: si parla di merito delle donne senza prima parlare di opportunità, si presenta il problema della conciliazione lavoro famiglia senza prima parlare della condivisione delle responsabilità da parte di uomini e donne, come ha fatto notare Susanna Camusso nel suo intervento al convegno. Non se ne devono rendere conto solo le donne, ma anche gli uomini. Questa alterazione della sintassi è in larga parte causata dal fatto che mancano i dati. Non ci sono ricerche costanti sul lavoro delle donne, con la conseguenza pericolosissima di ritrovarci a parlare di questioni importanti sulla base di opinioni personali o sintetizzando una specie di pensiero comune molto degradato.
La sua esperienza di donna lavoratrice in ambito teatrale come la definirebbe?
Io sono arrivata al teatro dopo un lungo percorso di studi che è culminato con il titolo di dottoressa di ricerca in Storia del Teatro Moderno e Contemporaneo. Loredana Stendardo è stata una mia collega all’università “L’Orientale”, prima di essere mia socia nella cooperativa, mentre Tiziana Sellato, che è la presidente di En Kai Pan, ha fatto una lunghissima gavetta sul campo ed era l’unica di noi ad avere già esperienza in ambito organizzativo e gestionale. Mentre studiavo, ero molto irrequieta, sentivo che il mio punto di vista era limitato. Ho cominciato a lavorare direttamente in forma privata e non ho vergogna di ammettere che quando abbiamo fondato la cooperativa, avevo la sensazione di non sapere fare niente. Ho cominciato come drammaturga e dramaturg della nostra compagnia teatrale e mi sono ritrovata a collaborare all’organizzazione e alla progettazione. È stato come essere travolti da uno tsunami, la mia vita è cambiata all’improvviso e la situazione in cui mi sono trovata è stata complicata dal fatto che mentre cerchi di costruire un’impresa il tempo passa. Io avevo 34 anni quando ho cominciato, non ero esattamente giovane, ho sperimentato come l’entusiasmo di trasformare le proprie idee in progetti, di costruire un’impresa dal nulla, di condividere tutto questo con altre persone, venga continuamente ostacolato dalle difficoltà economiche e dalla paura che il salto di qualità non avvenga mai, perché non dipende solo dalla felicità delle proprie intuizioni e dall’impegno che si profonde per realizzarle. A settembre 2020 abbiamo fatto un seminario nell’ambito dell’iniziativa Donne e impresa teatrale in Campania e dal confronto con le operatrici teatrali che sono intervenute è emerso che ci sentiamo tutte così. Non è un caso che questa percezione sia molto diffusa tra le donne della generazione che ha tra i 35 e i 45 anni e che, più di tutte, ha vissuto le trasformazioni degli ultimi venti anni, iniziando a lavorare nel pieno di una crisi economica globale e trovandosi adesso a difendere la propria impresa nel corso di una pandemia. Ritornando a me, adesso sono convinta che la cooperazione fosse fin dall’inizio lo strumento più adatto a me.
È cambiata rispetto ai primi anni di attività?
La cooperativa En Kai Pan è cambiata molto dalla sua fondazione. Sono cambiate, in parte, la composizione dei soci, la gestione, la visione alla base del lavoro. Nel 2019, dopo che il direttore artistico si è dimesso dalla sua posizione, abbiamo deciso di non cercarne un altro, ma di concentrarci su di noi come gruppo, aprendo nuove strade insieme. Questo è un cambiamento importante, perché, anche se la cooperativa è, dal punto di vista della governance, l’impresa più orizzontale di tutte, decidere che non debba esserci qualcuno che abbia di diritto l’ultima parola non è così facile da attuare nella pratica. Noi ci sforziamo di portare avanti solo i progetti in cui crediamo tutte e in cui tutte possiamo dare il nostro contributo alla pari. In questo modo siamo riuscite a sostenerci e ad andare avanti anche durante la pandemia. Il convegno è stato il simbolo di questa resistenza: avremmo dovuto farlo a ottobre 2020 in presenza, abbiamo dovuto rimandarlo senza avere una data certa e organizzarlo online in poche settimane, quando abbiamo saputo che non sarebbe stato possibile farlo in presenza. Abbiamo inviato centinaia di email, fatto centinaia di telefonate, abbiamo cercato di tenere vivo l’entusiasmo di tutte le partecipanti, perché le protagoniste delle due giornate sarebbero state loro. Ci siamo riuscite, perché abbiamo fatto la stessa cosa l’una con l’altra in tutto questo tempo.
Per le conclusioni del convegno, prevedete una pubblicazione?
Si, sicuramente pubblicheremo gli atti. Stiamo lavorando al piano dell’opera e scegliendo l’editore.
In realtà il convegno rientra in un più ampio progetto di ricerca. Ce ne può parlare?
Il progetto Talking about a revolution – La donna nella cooperazione è nato, come ho detto, nel 2017 e, sicuramente, non si fermerà con la pubblicazione degli atti del convegno. Abbiamo intrapreso anche la ricerca regionale Donne e impresa teatrale in Campania, che finora ha compreso la diffusione di due questionari, un seminario regionale e la raccolta di testimonianze e interviste alle professioniste della regione. È nostra intenzione, poi, riunire la rete di donne che abbiamo cominciato a costruire e capire insieme quali azioni compiere per rinforzarla. Ci ha stupito l’accoglienza che il progetto ha avuto tra tutte le persone che abbiamo coinvolto, l’aiuto che abbiamo ricevuto, l’entusiasmo della partecipazione. Non vogliamo dare per scontato questa apertura, chi lavora in ambito teatrale sa che non lo è. Vogliamo continuare a lavorare per consolidarla.
Dal convegno sono emerse tante tematiche. Si quale vi concentrerete per continuare la vostra ricerca?
Raccontare il lavoro è un atto tanto vitale quanto ormai desueto nel nostro paese. Noi continueremo a chiedere alle donne di teatro, a qualsiasi livello, di farlo.
Info: https://enkaipan.com/